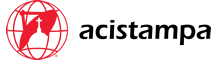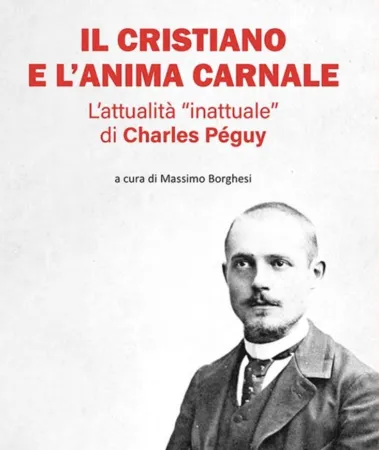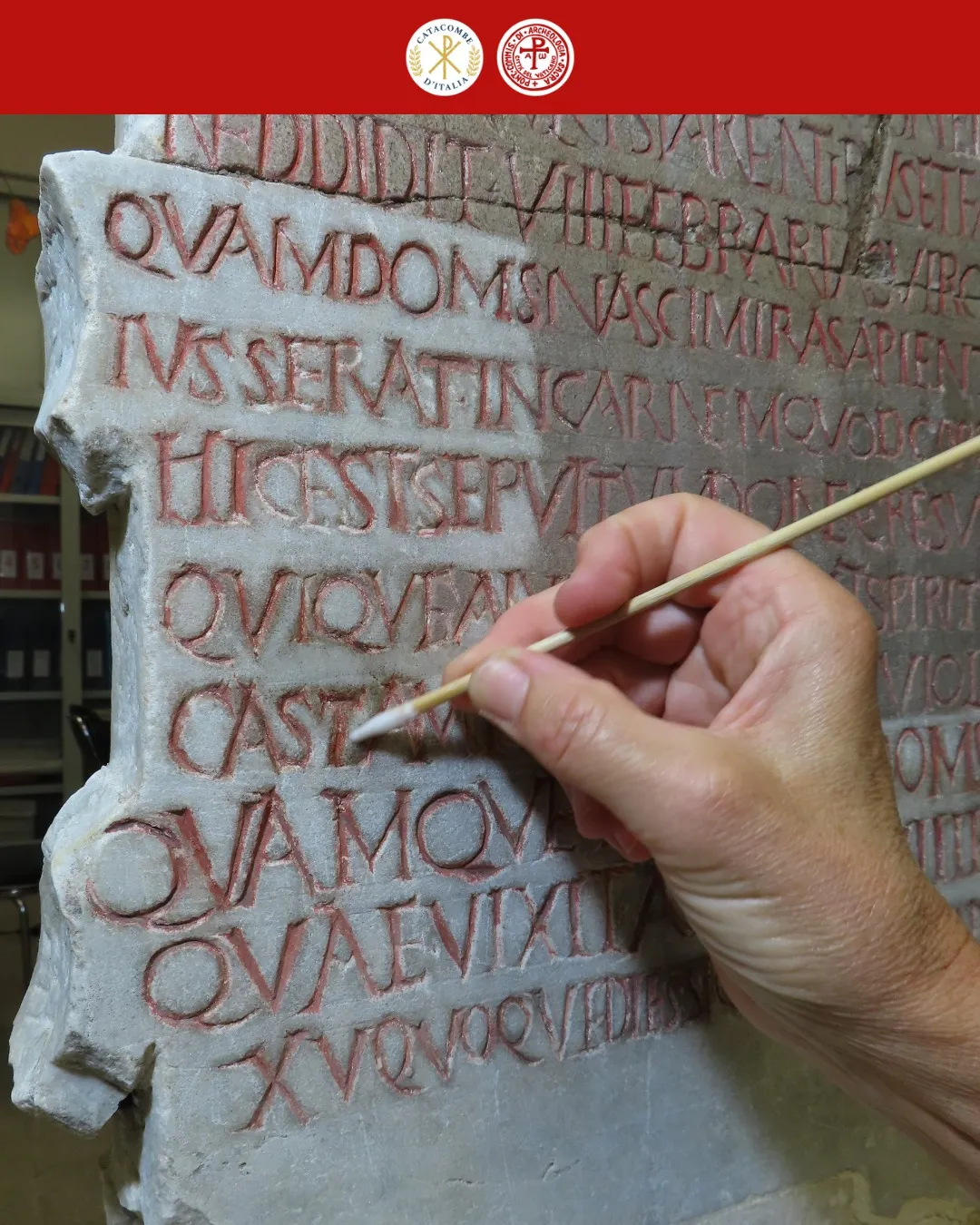“Il titolo del volume è tratto da una delle opere più importanti di Péguy, quella dedicata a ‘Véronique. Dialogo della storia e dell’anima carnale’, edita in Italia da Milella, Marietti, Piemme. Titolo ripreso in una bella mostra tenuta al Meeting di Rimini, nel 2014, che aveva come tema ‘Storia di un’anima carnale. A cent’anni dalla morte di Charles Péguy’, mostra curata da Piero Cappelli, Pigi Colognesi, Flora Crescini, Massimo Morelli. Il catalogo, pubblicato dalle Edizioni di pagina, era opera di Pigi Colognesi. Con l’espressione ‘anima carnale’ Péguy intende ciò che è proprio del cristianesimo, ovvero l’Incarnazione di Dio.
Per lui, che proveniva dalla militanza socialista e dall’impegno attivo durante l’affare Dreyfus, l’approdo alla fede non poteva certo significare una fuga spiritualistica dal mondo. Come bene scrive Hans Urs von Balthasar: Egli è indivisibile, e sta perciò dentro e fuori la chiesa, è la chiesa ‘in partibus infidelium’, dunque là dove essa dev’essere. Egli lo è grazie al suo radicamento nel profondo dove mondo e chiesa, mondo e grazia si incontrano e si penetrano fino a rendersi indistinguibili. Forse, dopo la lunga storia delle variazioni platoniche nella storia cristiana dello spirito, la chiesa non si è mai insediata in modo altrettanto deciso nel mondo, dove però l’idea di mondo rimane libera da ogni sfumatura di acritico entusiasmo, da ogni mitologia ed erotologia, come pura da ogni ottimistica fede nel progresso”.
Per quale motivo questa raccolta di saggi su Charles Peguy?
“Per rendere omaggio ad uno dei più grandi poeti cristiani del ‘900 in occasione dei 110 anni della sua morte avvenuta nei campi della Marna, all’inizio della prima guerra mondiale, nel 2014.
Occasione totalmente negletta in Italia dove l’opera di Péguy, diversamente da quanto accade in Francia, continua ad essere trascurata. Per questo il volume è costituito da saggi, passati e recenti, di autori italiani esperti della sua vita e del suo pensiero. Un capitolo è dedicato ad un appassionato studioso di Pèguy in Italia, Giaime Rodano venuto a mancare nel 2021. Si tratta di un libro originale che contribuisce, certamente, a riportare l’attenzione su questa straordinaria figura".
Pur convertito, non abbandonò il suo stile anticlericale: in quale modo amò la Chiesa?
“Amò la Chiesa da uomo libero, da cristiano libero, che diffidava del clericalismo in ogni sua forma. Come scriveva in ‘Veronique’: ‘Noi navighiamo costantemente tra due curati, noi manovriamo tra due bande di curati; i curati laici ed i curati ecclesiastici; i curati clericali anticlericali, ed i curati clericali clericali; i curati laici che negano l’eterno del temporale, che vogliono disfare, smontare l’eterno dal temporale, da dentro al temporale; ed i curati ecclesiastici che negano il temporale dell’eterno, che vogliono disfare, smontare il temporale dall’eterno, da dentro all’eterno’. Questi secondi, i ‘curati ecclesiastici’, erano, secondo Péguy, i più pericolosi per la fede, perché se si smonta il temporale dall’eterno non rimane più nulla, viene tolta la ‘carne’ della fede, la sua immersione storica, la salvezza del temporale”.
Però non rinnegò le idee socialiste?
“No, rimase ad esse fedele. Va detto, tuttavia, che il socialismo di Péguy era un socialismo ‘sui generis’, un socialismo morale, legato alla difesa di Dreyfus e contrario allo spirito anticlericale che animava il socialismo francese”.
Cosa era la speranza per lui?
“Era la virtù teologale che sosteneva la fede e la carità. La virtù dimenticata. Come ha detto papa Francesco nell’udienza generale del 27 settembre 2017: Un poeta francese (Charles Péguy) ci ha lasciato pagine stupende sulla speranza (‘Il portico del mistero della seconda virtù’). Egli dice poeticamente che Dio non si stupisce tanto per la fede degli esseri umani, e nemmeno per la loro carità; ma ciò che veramente lo riempie di meraviglia e commozione è la speranza della gente: ‘Che quei poveri figli, scrive, vedano come vanno le cose e che credano che andrà meglio domattina.
’L’immagine del poeta richiama i volti di tanta gente che è transitata per questo mondo (contadini, poveri operai, migranti in cerca di un futuro migliore) che ha lottato tenacemente nonostante l’amarezza di un oggi difficile, colmo di tante prove, animata però dalla fiducia che i figli avrebbero avuto una vita più giusta e più serena. Lottavano per i figli, lottavano nella speranza”.
Iscriviti alla nostra newsletter quotidiana
Ricevi ogni giorno le notizie sulla Chiesa nel mondo via email.
Nell'ambito di questo servizio gratuito, potrete ricevere occasionalmente delle nostre offerte da parte di EWTN News ed EWTN. Non commercializzeremo ne affitteremo le vostre informazioni a terzi e potrete disiscrivervi in qualsiasi momento.
Per quale motivo non sopportava un'anima 'abituata'?
“Péguy era stato allievo di Henri Bergson. A lui dedicherà la sua ultima opera ‘Note sur M. Bergson et la philosophie bergsonienne’, edito nei ‘Cahiers de la quinzaine’ nell’aprile del 1914. L’editrice Studium lo ha tradotto in italiano. Dal filosofo aveva tratto l’idea che l’esistenza è un ‘elan vital’ (slancio vitale, ndr.) e che l’abitudine è il grande pericolo. L’abitudine svuota gli ideali, toglie il soffio della vita, la novità dei giorni, lo splendore dei volti, delle avventure iniziate. L’abitudine logora anche la fede, toglie la speranza, riporta tutto a ‘routine’, a cose già viste.
Rende vecchio chi è ancora giovane, anticipa la morte e la senilità. Per questo non c’è che una medicina: la grazia, quella di Dio, che ridona novità al tempo della vita, ricrea l’esistenza, dona lo sguardo dell’alba del mondo. Senza l’esperienza della grazia, di una grazia presente, la Chiesa muore di inedia, di ritualismi, di sguardi rivolti al passato. Péguy è l’autore della grazia, immeritata, desiderata, amata”.