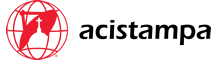Sarajevo , sabato, 6. giugno, 2015 14:30 (ACI Stampa).
“Io non odio nessuna etnia, non odio gli uomini in quanto categoria. Io so che quello che mi è stato fatto non può essere attribuito a un intero popolo.” Janko Samolikovic, di Visegrad, è uno dei sopravvissuti dei campi di prigionia della guerra dell’ex Jugoslavia. Ha fatto un percorso di riconciliazione, ha elaborato il dramma subito. Perché questo è quello che Papa Francesco ha trovato arrivando a Sarajevo: una città ferita, come la croce posta sull’altare che viene da un monastero distrutto durante la guerra, le cui ferite faticano a rimarginarsi.
Ma provano a rimarginarle alcuni sopravvissuti dei campi di prigionia. Ci sono un serbo, un croato e un bosniaco al tavolo organizzato il 5 giugno da Caritas, nella scuola cattolica di Sarajevo. “Quando parliamo insieme, ci rendiamo conto che la nostra sofferenza è comune,” dicono. Sono entrati nel programma Pro-Future: supporto psicologico, elaborazione del trauma subito, e poi racconto, nelle scuole, ovunque sia necessario, perché gli orrori della guerra non vengano dimenticati.
Janko è uno dei tre. “Avevo 23 anni quando la guerra ha toccato anche il mio paese. Prima, eravamo insieme serbi, bosniaci, croati. Non avevamo mai avuto alcun conflitto. Poi, lo scoppio della guerra. Mi hanno preso, mi hanno rinchiuso in una palestra insieme ad altri. Io sono molto emotivo, potete immaginare come mi sono sentito. Ho avuto sensazioni che non possono spiegare, perché un essere umano non dovrebbe mai avere quelle sensazioni.”
Racconta: “Andavo a dormire senza sapere se mi sarei svegliato la mattina dopo. Venivano interrogati in maniera brutale. Ci davano da mangiare ogni giorno un po’ di pane, un liquido che non ho mai capito cosa fosse. Ci davano 2 o 3 litri d’acqua da dividere in 7. E dovevamo anche lasciarne un po’ per quando qualcuno di noi sveniva, perché spesso svenivamo. Avevamo un secchio che doveva funzionare da toeletta.”
Aimir Omerspahic, da Sarajevo, racconta di essere stato catturato il 2 agosto del 1993, “prima dalla polizia jugoslava, poi consegnato a quella regolare serba. Cercavo di scappare, avevo un dito ferito. Un soldato mi picchiava sulla testa, mi sono protetto sulla mano. Mi ha picchiato sul dito ferito fin quando questo non è caduto. Un dolore atroce.”