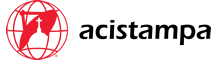Costantini, dice Parolin, “dimostrò un acume non comune nel decifrare la situazione ecclesiale a lui contemporanea”, rilevando in particolare “un perdurante, e ormai eccessivo, affidamento sulla componente estera della missione”, che si “manifestava nella presenza quasi esclusiva del clero straniero”.
Lungi dal voler stabilire “un processo contro la storia”, riconoscendo il merito di molti missionari stranieri, ma anche riconoscendo che gli aiuti umani dati dalle potenze straniere avevano anche portato “un peso morale passivo nell’economia dell’evangelizzazione”, e per questo era necessario passare al concetto di “Chiesa missionaria”, perché – scriveva Costantini – “noi siamo venuti in Cina non tanto per organizzare le missioni estere, ma per fondare la Chiesa”.
Parolin nota – ed è forse un riferimento in controluce anche alle critiche subite dall’accordo sino-vaticano – che le analisi di Costantini “non erano certo universalmente condivise”, anzi veniva spesso criticato e attaccato, anche dalla stampa locale.
Costantini, però, agì con “lungimiranza”, con la sicurezza che quello era l’approccio giusto, e con l’auspicio che “che la fede cristiana, nelle sue molteplici espressioni, potesse essere in Cina autenticamente inculturata, termine caro alla tradizione cattolica, che egli mai utilizzò ma che esprime appieno il suo pensiero e i suoi intenti”.
Ma – ed è qui un passaggio chiave del discorso del Segretario di Stato vaticano – “tale evoluzione non sarebbe stata pienamente compiuta – né sarebbe stata di per sé possibile – senza un altro fondamentale requisito: il dialogo diretto, ossia senza l’intermediazione delle Potenze, tra la Santa Sede e le Autorità del Paese. Nelle intenzioni di Costantini, i due elementi non potevano che muoversi di pari passo, come fattori complementari”.
È un punto di vista importante, specialmente posto di fronte a un vescovo nominato unilateralmente: non c’è Chiesa senza comunione con Pietro.
Ed è per questo che da un lato Costantini punta alla “inculturazione vera e propria, con l’utilizzo liturgico della lingua locale e lo sviluppo di forme espressive autoctone per veicolare l’unica ed immutabile fede”, con un grande lavoro sull’arte e sulla liturgia, ma allo stesso tempo sa che questa plantatio ecclesiae non può “tuttavia prescindere da un requisito fondamentale o, per meglio dire, da una condizione necessaria ed implicita, che ne sorreggeva l’intera struttura: ossia il legame con il Successore di Pietro”.
Non è un caso, nota il Segretario di Stato vaticano, che i primi vescovi cinesi vengono ordinati a Roma, dal Papa, nella Basilica Vaticana, con quello che Parolin descrive come un gesto di “intensa bellezza e grande eloquenza”.
In fondo, “lungo tutti i suoi scritti, il Delegato Apostolico ritornò più volte sul tema dell’unità tra il Papa e tutti i Cattolici sparsi nel mondo, qualunque fosse la loro appartenenza nazionale, chiarendo come proprio tale comunione fosse la migliore garanzia di una fede sottratta agli interessi politici esterni e saldamente ancorata nella cultura e nella società locali”.
Oltre l’inculturazione, Costantini puntava anche sul “dialogo diretto” tra Santa Sede e Cina, mostrando un “certo distacco dalle rappresentanze diplomatiche straniere”, per “evitare ogni possibile fraintendimento sulla natura della sua missione”, mantenendo rapporti costanti, ma sempre marcando “una distinzione tra la sua azione e la loro”. Atteggiamento, nota Parolin, che “derivava, piuttosto, dalla corretta convinzione che, in Cina, distinguere l’opera missionaria dalla politica internazionale fosse, in realtà, l’unico modo per tutelarla e per ridonarle autenticità e frutto: a tale scopo, era allora indispensabile che la Santa Sede e il Governo cinese imparassero a dialogare tra loro in modo diretto, senza intermediazioni e in una necessaria opera di reciproca scoperta. Solo così, si sarebbero potute superare le precomprensioni reciproche, in particolare quelle riguardanti il supposto carattere politico dell’attività missionaria cattolica”.
Sta, in queste parole, una difesa dell’approccio che ha portato all’accordo sino vaticano. Parolin si dilunga nel sottolineare che c’erano precedenti, come ad esempio “il primo progetto di un Sinodo per l’indigenizzazione della Chiesa cinese”, che era “stato lanciato già nel 1849, su stimolo dell’Istruzione Neminem profecto, emanata quattro anni prima dalla Congregazione de Propaganda Fide per rispondere all’urgenza di formare in tutto l’orbe cattolico un clero autoctono autosufficiente, fallito per le pressioni esterne così come falliti erano “i vari tentativi precedentemente attuati dalla Santa Sede e dalla Cina per stabilire reciproche relazioni” – e Parolin ricorda “l’ambasciata guidata nel 1860 da Luigi Celestino Spelta, allora Vicario Apostolico dello Hubei, incaricato da Pio IX di raggiungere a suo nome l’Imperatore Tonghzhi (pronuncia Tung gê)”, ma anche “i progetti di nuovi contatti maturati durante il Concilio Vaticano I o gli approcci tentati da Leone XIII nel 1882”.
E ancora, “i negoziati del 1886 con la nomina di Mons. Antonio Agliardi a Nunzio Apostolico in Cina, che poi dovette essere ritirata di lì a breve; o le trattative che nel 1917 portarono all’ulteriore designazione di un Rappresentante Pontificio in Sinis – questa volta individuato in Mons. Giuseppe Petrelli – la quale anche allora dovette, però, essere annullata”.
Iscriviti alla nostra newsletter quotidiana
Ricevi ogni giorno le notizie sulla Chiesa nel mondo via email.
Nell'ambito di questo servizio gratuito, potrete ricevere occasionalmente delle nostre offerte da parte di EWTN News ed EWTN. Non commercializzeremo ne affitteremo le vostre informazioni a terzi e potrete disiscrivervi in qualsiasi momento.
Insomma, la Santa Sede ha una tradizione diplomatica di contatti con la Cina, ha cercato da sempre un accordo. Parolin chiosa semplicemente che “i tempi, evidentemente, non erano maturi e le pressioni delle Potenze si erano rivelate decisive”.
Va notato anche l’intervento del vescovo Shen Bin, pure lui concentratosi sulla figura dell’arcivescovo Costantini e sul suo lavoro per superare la questione dei “patronati” delle potenze straniere, rinunciando a privilegi e agevolazioni che la Chiesa aveva ottenuto attraverso i “Trattati ineguali” firmati tra il governo Qing e le potenze occidentali. E questo perché – ricorda Shen Bin – Costantini sottolineava che “un cattolicesimo che è stato a lungo dipendente da missionari stranieri, dalla protezione di potenze straniere, e che viene definito dai cinesi ‘religione straniera’, non andrà lontano in Cina, in un Paese che ha una profonda e lunga tradizione culturale”.
Shen Bin ricorda l’intervento delle potenze straniere in Cina in nome dei Trattati ineguali dopo la guerra dell’Oppio del 1840, sottolinea la mentalità “coloniale” di alcuni missionari, mette in luce come il crescere del sentimento nazionalista cinese fa intensificare “il conflitto tra la Chiesa e il popolo”.
Fu a quel punto, ricorda il vescovo di Shanghai, che la Santa Sede crea un nuovo orizzonte evangelico, e pubblica il documento “Sul clero autoctono”, pubblicato dalla Congregazione De Propaganda Fide con l'approvazione del Papa Gregorio XVI nel 1845, e nella Lettera Apostolica “Maximum Illud”, pubblicata da Benedetto XV nel 1919.
Nel 1922, viene inviato in Cina l’arcivescovo Costantini, che promosse il Concilio dei vescovi di Shanghai del 1924, cosa che portò poi alla consacrazione dei sei vescovi cinesi a Roma nel 1926. Shen Bin nota che “a causa delle resistenze che ne seguirono, il Concilio di Shanghai non portò a un cambiamento immediato e radicale nella Chiesa in Cina”, e rimasero esigui i numeri sul clero cinese, tanto che “al momento della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, solo 29 delle 137 diocesi cinesi avevano vescovi cinesi e solo 3 dei 20 arcivescovi erano cinesi”.
Shen Bin delinea quattro punti per il futuro. Il primo: “Lo sviluppo della Chiesa in Cina deve essere fedele al Vangelo di Cristo”. Il vescovo di Shanghai sottolinea che la Cina è sempre rimasta intatta alla sua fede cattolica, e sottolinea che “la politica della libertà religiosa attuata dal governo cinese non ha alcun interesse a cambiare la fede cattolica, ma spera solo che il clero e i fedeli cattolici difendano gli interessi del popolo cinese e si liberino dal controllo di Potenze straniere”.