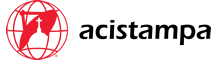Pechino , venerdì, 23. maggio, 2025 9:00 (ACI Stampa).
Il pellegrinaggio al Santuario di Sheshan, vicino Shanghai, caratterizza il 24 maggio, festa di Maria Ausiliatrice, patrona della Cina. Ma il 24 maggio è anche, dal 2007, giornata di preghiera per i cattolici di Cina, stabilita da Benedetto XVI dopo la sua densa lettera ai cattolici di Cina, ancora non recepita del tutto. L’anniversario e la ricorrenza sono festeggiate dalla Cina con un po’ di restrizioni in più sui cattolici, mentre la sede vacante è stata celebrata dal governo di Pechino con la nomina unilaterale di due vescovi ausiliari, uno addirittura nella diocesi di Shanghai, dove un ausiliare c’è ma è agli arresti domiciliari dal 2012.
È il segno di una difficile situazione, e un equilibrio ancora più difficile, che rendono la Cina un territorio missionario da gestire in maniera creativa. Mentre il Cardinale Chow, vescovo di Hong Kong, fa sapere che Leone XIV è stato più volte in Cina, c’è uno studio, pubblicato ai tempi del Conclave sul sito web cattolico cinese Xinde, che ha fornito la storia della parola Papa in mandarino. E il senso di quel lavoro di traduzione è anche al centro dell’incomprensione del governo cinese per la figura del Papa.
Ma andiamo con ordine. Nel Seicento, i missionari occidentali – specialmente gesuiti –che avevano avuto contatti con la raffinata corte di Pechino e con i ceti alti della società cinese contribuirono a diffondere in Europa una grande ammirazione per quel Paese e per quella civiltà. Poi venne la colonizzazione. Alla fine del Settecento, la Gran Bretagna introdusse in Europa un’immagine diversa della Cina: Paese arretrato, corrotto, governato da gente inaffidabile. Le affermazioni inglesi trovarono gioco facile in una Cina che viveva una fase di grande decadenza, cominciata nel XIX secolo, che porterà alla caduta della dinastia Qing e alla proclamazione delle Repubblica nel 1911.
Sono processi da cui non sono estranee le Chiese. Se prima penetrare in Cina era difficile per i missionari, e richiedeva un grande lavoro di mediazione tra le culture, le guerre dell’oppio, dalla metà dell’Ottocento, segnano una stagione di maggiore libertà d’azione per i religiosi stranieri, e vi arrivano a frotte, cattolici e protestanti.
Una libertà di azione che si inserisce in un rinnovato slancio missionario della Chiesa tutta, che tocca il suo culmine sotto Leone XIII. Sono migliaia i missionari europei che si trasferiscono in Cina. Entrano in contatto non con i ceti alti, ma con uomini e donne che non erano mai usciti dai loro villaggi e ce non avevano mai incontrato neanche cinesi di altre regioni. Ma erano anche missionari che non conoscevano la lingua, si muovevano sulla base di valutazioni inadeguate delle tradizioni religiose locali, non comprendevano neanche la struttura della società cinese. Il divario con i missionari guidati da padre Matteo Ricci era evidente. E in Cina – dove padre Matteo Ricci era addirittura venerato – avvertirono questa differenza in maniera quasi dolorosa. Anche perché i nuovi missionari non riuscivano a familiarizzare nemmeno con i fedeli o i sacerdoti cinesi e i religiosi stranieri. Contrariamente a quanto chiesto da Adriano VII, affidavano con riluttanza le responsabilità pastorali e amministrative agli indigeni. Pensavano che l’identità cinese fosse così forte da ostacolare l’evangelizzazione.