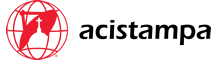Il primo incontro con l’ISIS è stato scioccante, perché basta sentire il nome di ISIS e uno trema. Due giorni dopo il loro ingresso, viene uno, bussa alla porta del convento, chiede di me. La suora apre la porta, dicendo che non c’è. Poi la suora viene da me ed io sono impallidito, perché non sapevo come comportarmi. Sono andato a fare una preghiera: ‘Dio, Signore, questo gregge che ho non è mio, è tuo. Dammi soltanto la saggezza di saper fare e saper rispondere’.
L’indomani, alle nove in punto, due macchine blindate arrivano e si fermano alla porta del convento. Tutti armati, con i Kalashnikov a tracolla, cinture minate. Uno alto un metro e novanta, con le spalle larghe, scende, mi saluta con arroganza e mi dice: ‘Sono Abou Ayyub al-Tunisi’. Io, allo stesso tono, rispondo: ‘Sono padre Hanna Jallouf’. Perché nella psicologia, al primo incontro, se tu stai all’altezza, allora c’è rispetto; se no ti ammazza, ti stermina. ‘Va bene, avanti, si accomodi’. Voleva entrare al convento. ‘Dove vai? Qui è terra sacra: non puoi entrare con le armi, per favore mettile fuori’. Si è infuriato: ‘Noi entriamo con le nostre armi dove vogliamo, scassiamo le porte, scassiamo tutto; anche nelle moschee possiamo fare quello che vogliamo’. Io rispondo: ‘Se tu credi che le tue armi ti proteggano, benvenuto. Avanti’. Allora è entrato lui con un altro, già coperto in faccia”.
Con il passare dei giorni la fiducia è arrivata: “In quei giorni che sono rimasti da noi avevano molta fiducia nei cristiani. Se volevano qualcosa, per esempio acqua o da bere, o così, chiedevano a noi: mai hanno chiesto un bicchiere d’acqua ai musulmani. E di più: i musulmani intorno, che avevano preso le nostre macchine e i nostri strumenti di agricoltura, di notte cominciavano a restituirli e ci dicevano: ‘Per favore non dite che erano rubati e chi li ha rubati, sennò questi ci ammazzano: o tagliano la testa o tagliano la mano’. Sono rimasti da noi 105 giorni. Non è rimasto nessun fornicatore, nessun ladro, nessun bugiardo: tutti sono scappati via per paura di essere sterminati”.
Ha concluso la sua testimonianza sottolineando la necessità di testimoniare il Vangelo attraverso la vita: “Non alziamo il Vangelo proclamandolo a parole soltanto: dobbiamo proclamare il Vangelo con la nostra vita. Perché a Knaye abbiamo parlato ai musulmani dicendo che il cristiano non mente, il cristiano è fedele, il cristiano ha la porta di casa aperta a tutti i pellegrini, il cristiano è leale. Questi sono i valori che il cristiano deve vivere. Non soltanto bere alcol o altre cose, o vestire con la minigonna e tutto questo. Noi dobbiamo essere pacificatori, portatori del messaggio di Cristo, perché siamo chiamati a questo compito”.
Mentre dall’Africa la suora missionaria agostiniana, Lourdes Miguélez Matilla, ha raccontato la sua esperienza maturata grazie anche alla fedeltà dei martiri a Cristo ed al popolo algerino: “La mia vita ormai si era radicata in questo popolo. Avevo iniziato a conoscere e ad amare la gente e sentivo il loro affetto e la loro fiducia. Ormai mi trattavano come una di loro. E poi ho scoperto l’importanza di stabilire delle relazioni basate sul rispetto e sull’accettazione delle differenze e di vivere con la condivisione della fede. Di fatto, sul lavoro, parliamo di Dio molto di più con i musulmani, con gli algerini, rispetto a quando ci ritroviamo tra cristiani.
Ho appreso che non ero andata lì ad imporre qualcosa, anzi, ero lì per condividere, per lavorare insieme e per valorizzarlo. Poco a poco, il mio cuore e il mio essere si aprirono e le relazioni umane cominciarono ad approfondirsi, fino al punto da crearmi delle amicizie solide, fedeli e durature che ho tuttora. Grazie a queste amicizie è cresciuta la mia fiducia in Cristo e il mio desiderio di seguirlo ancora più da vicino. E’ aumentata anche la mia fiducia nei confronti della Chiesa e del popolo algerino”.
Però dopo il martirio dei 19 beati aveva dovuto abbandonare il Paese, ma ora è ritornata: “Adesso il nostro centro di accoglienza e di amicizia è un luogo conosciuto e apprezzato in tutto il quartiere. E con l’aiuto di animatrici algerine, organizziamo tutta una serie di laboratori di cucito, di bigiotteria, di pittura per le donne. Ogni mese diamo spazio a una famiglia algerina che viene dalla Francia per distribuire derrate a 70 famiglie povere che ci chiedono di selezionare con anticipo.
E le stanze in cui vivevano le sorelle che sono state assassinate e che rimasero deserte per tanti anni, adesso sono state trasformate in uno spazio di vita, solidarietà, di felicità e speranza. Sono un luogo in cui si imparano cose, si rompono barriere e si condivide tutto. E senza quasi cercarlo, ci siamo trasformate ad essere un luogo di ascolto e di aiuto per molte persone con problemi familiari, di salute, solitudine, povertà. E questa fiducia ce la offrono perché sanno che siamo delle religiose. E credo che la nostra umile presenza contribuisca ad alleviare la sofferenza delle persone e a motivarle, a incitarle di fronte alle difficoltà e a rendere la vita più umana, più attraente e più bella. La nostra presenza, allo stesso tempo, è raggiante e discreta e si ispira alla vita di Gesù a Nazareth”.
Mentre dal Sud Sudan è arrivata la testimonianza di mons. Christian Carlassare, vescovo di Bentiu, 1.200.000 abitanti di cui 400.000 cattolici: “Annunciare il Vangelo e sostenere la dignità e la promozione umana sono le due traiettorie del nostro impegno. L’educazione è la chiave, Solo il 2% dei bambini frequenta la primaria, il 5-6% le superiori. Le tre scuole nelle parrocchie principali e i duemila iscritti all’Università Cattolica sono reali segni di speranza… La nostra prima azione pastorale è infondere speranza. In questi anni sono stato sfamato, nascosto, protetto. Ho toccato con mano l’enorme generosità di questo popolo”,
Ed infine: “La Chiesa in Sud Sudan ha sempre evangelizzato anche valorizzando l’importanza dell’istruzione come strumento importante verso una piena liberazione da schiavitù legate alla cultura tradizionale, all’appartenenza di sangue e alla posizione economica. Nelle scuole cattoliche vediamo una nuova generazione emancipata da narrative di pregiudizio, di paura e di rancore, e pronte a riscrivere una nuova storia di comprensione, di coraggio, e di riconciliazione”.
Anche dall’Europa sono giunte testimonianze di perdono, come quella della giornalista-documentarista russa Katerina Gordeeva, che ha raccontato la guerra dal fronte ucraino-russo vissuto dalle popolazioni, e nello scorso anno ha vinto il premio ‘Anna Politkovkskaja’ come giornalista indipendente per i reportage sulle guerre in Cecenia, Iraq e Afghanistan, presentando il libro ‘Oltre la soglia del dolore’, una raccolta di 24 storie ucraine e russe che raccontano la tragedia della guerra, vissuta dalla popolazione dei due Stati, come ha scritto nella prefazione Dmitrij Muratov, premio Nobel per la pace e caporedattore di Novaja Gazeta: “Katerina Gordeeva è diventata un’alternativa unipersonale ad una colossale macchina di propaganda”.
Lei stessa ha spiegato il motivo: “Ho deciso di raccogliere le voci di russi e ucraini sul campo, di documentare tutto, perché un domani i miei figli possano conoscere la storia per come è stata, non per come l’ha narrata la propaganda. E perché se in futuro ci saranno dei processi, queste testimonianze possano servire alla verità e alla giustizia”.
Iscriviti alla nostra newsletter quotidiana
Ricevi ogni giorno le notizie sulla Chiesa nel mondo via email.
Nell'ambito di questo servizio gratuito, potrete ricevere occasionalmente delle nostre offerte da parte di EWTN News ed EWTN. Non commercializzeremo ne affitteremo le vostre informazioni a terzi e potrete disiscrivervi in qualsiasi momento.
Nel reportage, diventato libro, Katerina Gordeeva ha incontrato molte persone, tutte segnate fisicamente o mentalmente dal conflitto, come Danila, mutilata ad una gamba, o Rita, che ha sposato un coreano e ha deciso che in Ucraina non tornerà mai più e poco importa se la prenderanno i russi o se resterà in mano agli ucraini: “Aveva studiato come otorino pediatrico, in mezzo alla confusione della guerra si ritrova nel sangue, a ricucire gli arti strappati dalle esplosioni delle bombe, e a domandarsi se è per questo che ha studiato, se è per questo che deve vivere”.
Un racconto che non lascia alibi alla nostra dimenticanza: “Ho girato tanti video di queste interviste, ma le voci di quella gente mi tormentavano e ho scelto di metterle anche su carta. Anche se oggi c’è poco spazio per il giornalismo indipendente in Russia, ci sono le persone”, come la piccola Katja: “Stavo parlando con la madre, una sarta il cui marito, muratore, si trovava al fronte. Parlavamo della guerra e la donna raccontava dei morti, dei mutilati, della paura del futuro. Non so da quanto tempo stessimo lì. All’improvviso quella bimba, che poco prima stava guardando Peppa Pig, comincia a tirare dei piccoli pugni alla mamma implorandola di smetterla di parlare di queste cose. ‘E di cosa dovremmo parlare, Katja?’, le ho domandato con l’oscena speranza dell’adulto che i bambini, nella loro purezza, sappiano tutto e meglio. ‘Del bene’, mi ha risposto.’“Del bene?’. ‘Sì’. Poi ha serrato le spalle e ha chiesto solo alla madre di prenderla in braccio e di poter andare a dormire”.
Ed ha detto che non è possibile far finta che la guerra non generi dolore, perché non ci ‘tocca’: “Io sono rimasta sconvolta quando ho capito che i miei concittadini erano disposti a far finta di niente, a nascondere la testa sotto terra, per conservare una presunta normalità. Non tutti, certo, perché non posso tacere ad esempio lo straordinario moto umano di famiglie che si sono fatte in quattro per ospitare i profughi ucraini nelle loro case, a Rostov o nei centri di accoglienza temporanei…. Oltre la soglia del dolore c’è la vita. E, come mi ha detto una profuga ucraina, forse un livello superiore di misericordia”.