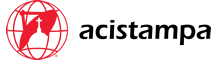Avvenne così che 135 sacerdoti furono deportati, vale a dire i 2 terzi dei sacerdoti di Cuba, mentre Fidel Castro aumentava la pressione contro ogni forma di opposizione, inclusa la Chiesa Cattolica.
Ma la Chiesa non ruppe le relazioni diplomatiche con Cuba. E Fidel Castro non le chiuse. Questo perché “il ruolo di mediazione della Santa Sede – spiega Kuivala – è stato, in realtà, il fattore più significativo che ha fatto mantenere prima di tutto l’autonomia della Chiesa di Cuba, e in secondo luogo una coesistenza tra Chiesa e Stato mutualmente riconosciuta, sebbene forzata”.
Non solo. Il governo – si legge in un memorandum del 1961 – cercò opportunità di coesistenza tra la Chiesa e la rivoluzione a Cuba, e persino di avere l’appoggio della Chiesa nel progetto, che non significava avere l’appoggio della Chiesa cubana.
Succede sempre così. Da una parte, si cerca di annullare il sentimento religioso locale, e si toglie alla Chiesa tutto quanto è possibile in termini di scuole e strutture. Ma, dall’altra, si riconosce l’influenza della Santa Sede.
D’altro canto, la Santa Sede ha sempre l’approccio di mantenere aperto il dialogo. Così, la presenza diplomatica vaticana en la isla non cessa nemmeno quando Cuba, per un periodo a metà degli Anni Sessanta, decide di mettere da parte la sua presenza diplomatica in Vaticano.
Importantissimo il ruolo dei nunzi. All’apice del conflitto, monsignor Cesare Zacchi diventa il nunzio a Cuba, e lì – spiega il professor Kuivala – è “ancora ricordato come un diplomatico pieno di risorse”, che riuscì persino a richiamare a Cuba i seminaristi che erano stati inviati a Roma a concludere i loro studi durante il periodo della revolucion.”
Ma il lavoro di monsignor Zacchi è più ampio, perché per il monsignore Cuba era “un microcosmo della Chiesa che stava affrontando la modernità negli anni Sessanta”, un luogo che preconizzava quello che sarebbe successo nel mezzo del mondo, e così il Concilio Vaticano II era “una chiave cruciale per allentare le tensioni con Cuba”.
Così, il lavoro di monsignore Zacchi fu anche quello di creare una Chiesa aperta al mondo, che fu alla base della possibilità della Chiesa di emergere di nuovo nella sfera pubblica negli Anni Ottanta, quando cominciò il disgelo.
“In Cuba – conclude Kuivala – la diplomazia non è stata solo delineata in dichiarazioni e visite di Stato, ma in incontri informali, sedute di nuoto subacqueo e ricevimenti alla nunziatura”.
È qui che la storia del professor Kuivala si incrocia con quella del professore Marie Gayte-Lebrun, dell’Università di Tolone, che si è concentrata invece nei suoi studi sul ruolo della Santa Sede nella mediazione tra Cuba e Stati Uniti.
Ancora una volta, è interessante notare come le diplomazie del mondo guardino alla Santa Sede. Lo fanno in generale con un intento politico, sperando di utilizzare il parere imparziale della Santa Sede in un dibattito ideologico.
Giovanni Paolo II decide di viaggiare a Cuba, ed è una cosa nell’aria da tempo, sebbene proprio gli Stati Uniti siano preoccupati dall’idea, considerando la possibilità che il regime si senta rinforzato. Ma Giovanni Paolo II è irremovibile.
Iscriviti alla nostra newsletter quotidiana
Ricevi ogni giorno le notizie sulla Chiesa nel mondo via email.
Nell'ambito di questo servizio gratuito, potrete ricevere occasionalmente delle nostre offerte da parte di EWTN News ed EWTN. Non commercializzeremo ne affitteremo le vostre informazioni a terzi e potrete disiscrivervi in qualsiasi momento.
Il professor Gayte, tra l’altro, fa notare un criterio fondamentale dei viaggi papali: il Papa vuole andare per rivitalizzare la Chiesa di Cuba, per contrastare il calo delle vocazioni.
I motivi della Chiesa sono sempre pastorali. La sua diplomazia ha sempre un punto di partenza pastorale. L’agenda internazionale della Santa Sede è il bene comune.
Gayte-Lebrun nota che, nel momento in cui il viaggio di Giovanni Paolo II è deciso, gli Stati Uniti cominciano a insistere che “il Vaticano chieda maggiore libertà e dia forza alla società civile, come aveva già fatto in Polonia, portando eventualmente a un cambio di regime”.
Ma non è quello che vuole la Chiesa. Durante il viaggio a Cuba, Giovanni Paolo II chiede maggiore libertà, critica l’ideologia marxista, esorta Cuba ad aprirsi al mondo, ma appare anche a fianco di Fidel Castro e stigmatizza l’embargo USA.
E questo dimostra che la prima preoccupazione della Santa Sede non è politica. La Santa Sede vuole sì una transizione democratica, ma vuole che questa abbia luogo in un tempo ragionevolmente lungo, perché c’è la preoccupazione che un cambiamento improvviso “in una situazione economica difficile, porti ad uno spargimento di sangue”.
È una posizione che è sempre stata mantenuta dalla Santa Sede. Anche Benedetto XVI andò a Cuba e mantenne la stessa posizione, e così fece Papa Francesco. Ma allora come si pone la mediazione tra Stati Uniti e Cuba?