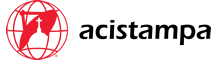Ed è lì, che “significativamente” Benedetto XV “preferì, anziché di giustizia, parlare di equità, ossia della giustizia animata dalla carità cristiana, facendo appello al fondamentale precetto evangelico dell’amore del prossimo e del perdono delle offese, ma anche a quello politico dell’impossibilità di realizzare richieste massimaliste che non erano in grado di assicurare la convivenza umana e minacciavano di suscitare, una volta ripresosi l’avversario, reazioni rovinose per la pace e per gli stessi vincitori di ieri”.
È un concetto valido anche per le mosse della diplomazia pontificia di oggi. E dal testo del cardinale Parolin si possono comprendere, in qualche modo, anche le preoccupazioni di oggi.
Il Cardinale Parolin parte dalle parole del diplomatico pontificio Ermenegildo Pellegrinetti, che fu poi nunzio apostolico a Belgrado e cardinale, e che commenta con il visitatore apostolico di Polonia Achille Ratti, futuro Papa Pio XI, la fine della guerra. Pellegrinetti parla della “catastrofe dell’Austria”, che è “spaventevole e al tempo stesso mirabile”, considera finita la sua missione storica, sottolinea che in Oriente comincia una epoca nuova “senza impero turco, senza impero austriaco, senza zarismo, prende una piega tutta nuova”.
Fu in quel tempo che Benedetto XV decide di aprire il Pontificio Istituto di Studi Orientali, è in quei tempi che comincia a maturare la Maximum Illud, l’enciclica del 1919 sulla nuova evangelizzazione che slega definitivamente la Santa Sede dalle potenze coloniali.
Era il segno che la Santa Sede guardava al futuro come una opportunità, ma senza mettere da parte l’idea che si sarebbe potuti entrare in una situazione tirannide, a seconda “che saranno informati a principi schiettamente cristiani od a quelli di un laicismo miscredente ed ateo”, avvertiva l’Osservatore Romano dell’1 gennaio 1919.
Benedetto XV vide lì il compito da svolgere, sia dal lato religioso-pastorale sia da quello politico diplomatico. E lo compì con una “piuttosto piccola ma fedelissima schiera di diplomatici, a quel tempo ancora tutti italiani, formatisi nel vecchio mondo diplomatico di cancellerie, salotti e lingua dotta, e da un giorno all’altro costretti ad adattarsi ad ambienti, linguaggi e interlocutori nuovi”.
Il consolidamento della pace fu la prima tappa di questo cammino, e per questo guardò con attenzione alle trattative di pace, sebbene la Santa Sede non vi potesse partecipare “sia per via dell’articolo 15 del Patto di Londra, ma anche per l’intervento delle forze laiciste decise a osteggiare un’interferenza religioso-ecclesiastica negli organismi internazionali”.
Benedetto XV però non lesina gli sforzi. Scrive la breve enciclica Quod iamdiu del 1° dicembre 1918, e avverte che “il compito del futuro Congresso sarebbe stato quello di combinare una pace giusta e duratura”, invitando “i vescovi a far pregare perché vi si concretasse ‘quel gran dono di Dio ch’è la vera pace fondata sui principi cristiani’”.
Ma quel lavoro non si fermò lì. Il Cardinale Parolin ricorda che “il Pontefice inviò il capo della sua diplomazia, l’abile segretario per gli affari ecclesiastici straordinari Bonaventura Cerretti, in Francia, Belgio, negli Stati Uniti e in Inghilterra per promuovere da parte degli episcopati nazionali e dell’opinione pubblica cattolica un’azione sui rispettivi governi nel senso desiderato dalla Santa Sede”.
E Cerretti era a Parigi durante la conferenza di pace, sebbene escluse dalle trattative, lavorando incessantemente e riuscendo anche “a mitigare la sorte dei luoghi santi e delle missioni cattoliche tedesche nelle colonie delle quali la Germania sconfitta fu privata, e anche ad avviare discreti contatti con gli interlocutori italiani per districare lentamente l’irrisolta questione romana”.
Un impegno basato proprio sul principio di equità, che chiedeva di fatto ai vincitori di “non abusare della loro forza del momento”, e che indicava che la Santa Sede considerava i trattati di pace “benvenuti perché sanzionavano la cessazione delle ostilità e aprivano le possibilità di rinnovata collaborazione tra i popoli, ma accettati con perplessità e critica, quando la pace rimaneva sulla carta anziché nei cuori degli uomini e le esigenze della carità cristiana non erano soddisfatte”.
Un dualismo che si trovava anche nel giudizio della Società delle Nazioni, che aveva un carattere universale e principi vicini a quelli delineati da Benedetto XV, ma aveva anche “un carattere liberal-laicista radicato nell’ideologia dell’umanitarismo laico, gli influssi della massoneria internazionale che subiva e l’esclusione del Pontefice da questo organo internazionale”, cosa che “non poteva non suscitare riserve e distanze, non impedendo comunque ai diplomatici papali di sostenere singole iniziative volte a buon fine”.
Iscriviti alla nostra newsletter quotidiana
Ricevi ogni giorno le notizie sulla Chiesa nel mondo via email.
Nell'ambito di questo servizio gratuito, potrete ricevere occasionalmente delle nostre offerte da parte di EWTN News ed EWTN. Non commercializzeremo ne affitteremo le vostre informazioni a terzi e potrete disiscrivervi in qualsiasi momento.
Tra le sfide della diplomazia papale post-bellica, il crollo della monarchia asburgica, l’ultima grande monarchia cattolica. Subito, già poco dopo l’armistizio di Villa Giusti, viene chiesto a monsignor Teodoro Valfré di Bonzo, che era capo della nunziatura di Vienna, di mettersi “in rapporti amichevoli” con “le diverse nazionalità dello Stato austro ungherese che si sono costituiti recentemente in Stati indipendenti”, chiedendo di fatto di “costruire nuovi canali per un’efficace comunicazione e azione diplomatica, in modo da salvaguardare gli interessi della Chiesa e, attraverso una rapida azione in tempi cruciali, di assicurarle il debito posto nelle nuove compagini statuali”.
In questa situazione difficile, emergono figure di nuovi diplomatici apostolici, descritti dal Cardinale Parolin come “personaggi straordinari, quasi tutti divenuti cardinali o persino Pontefici”. Si tratta di Achille Ratti e Lorenzo Lauri in Polonia, Clemente Micara e Francesco Marmaggi in Cecoslovacchia, Lorenzo Schioppa e Cesare Orsenigo in Ungheria, Ermenegildo Pellegrinetti nel Regno dei Serbi, Croati e Sloveni (più tardi Jugoslavia), Francesco Marmaggi e Angelo Maria Dolci in Romania, e tanti altri.
La seconda sfida riguarda la rivoluzione bolscevica in Russia, “che spazzò via il governo zarista con la sua persecutoria ostilità nei confronti della Chiesa cattolica, sostituendolo, dopo una breve fase di aspettative ottimiste nel Palazzo apostolico, da un regime oppressivo e nemico della legge divina e naturale mai conosciuto prima”.
La diplomazia pontificia non ebbe “timore nemmeno di entrare in contatto con i rivoluzionari bolscevichi in frac e iniziare delle trattative diplomatiche per assicurare la sopravvivenza al cattolicesimo nell’Unione Sovietica”, e questo nonostante – e proprio per questo – la situazione dei cattolici nei confini sovietici era diventata drammatica.
Sottolinea il Cardinale Parolin: “Le trattative fallirono, ma la Santa Sede riuscì almeno a inviare nell’Unione Sovietica un’imponente missione caritativa, contribuendo in tale modo a salvare migliaia di vite umane. Il cristianesimo in Russia e nell’Unione Sovietica rimase comunque una delle preoccupazioni maggiori di tutti i Pontefici del travagliato XX secolo”.
Eppure, la Santa Sede riuscì a fare molto, nonostante le difficoltà create anche dall’irrisolta Questione romana, tanto che nel settembre 1914 la Santa Sede aveva relazioni con solo 17 stati, mentre nel gennaio 1922 ce n’erano 27.